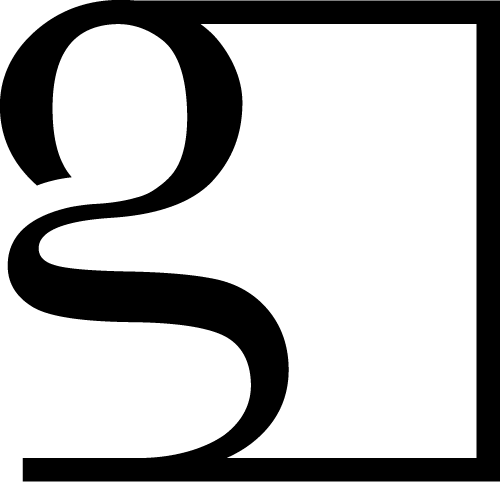Molti considerano gli scacchi un gioco dove con molta disciplina e studio si può diventare ottimi giocatori, ma solo con un’innata immaginazione si può aspirare a essere campioni.
L’immaginazione è l’elemento in grado di anticipare le mosse dell’avversario, di tessere tele imprevedibili, di visualizzare uno schema coerente e lineare che passo dopo passo ci conduca alla vittoria.
Quanta immaginazione serve all’Inghilterra per giocare correttamente la partita del referendum sulla permanenza nell’Unione Europea? Tanta, tantissima. E non sarebbe comunque sufficiente a delineare uno scenario del tutto esaustivo su ciò che scaturirà dalla vittoria del “Leave” o del “Remain”. Così, mentre il dibattito pubblico italiano è monopolizzato dall’avvicinarsi dei ballottaggi amministrativi e dal referendum sulla Riforma costituzionale, oltre Manica si sta giocando il futuro non solo dell’Inghilterra, ma dell’Europa intera.
Brexit, l’acronimo di Britain Exit, suona quasi provocatorio nel voler racchiudere in sei lettere tutta la complessità e le incertezze legate a un tema che da mesi ormai domina lo scenario politico-comunicativo inglese. Siamo tutti spettatori interessati dall’esito di questa partita, più o meno consapevoli delle conseguenze che, a prescindere dall’esito finale, certamente subiremo.
Lo sanno bene gli inglesi che nel prendere le parti del “Leave” o del “Remain” hanno messo da parte il tradizionale aplomb che li contraddistingue. Vuoi per l’importanza dell’appuntamento, vuoi per la necessità di semplificare dal punto di vista comunicativo un argomento particolarmente spinoso, vuoi perché dietro al palcoscenico principale del Sì o No alla permanenza in UE, si sta consumando una lotta interna al partito dei Tories per la leadership dei prossimi anni.
È spostandosi su quest’ultimo piano che lo scontro tra “Leave” e “Remain” assume una personalizzazione nelle figure dei loro più autorevoli esponenti, rispettivamente l’ex Sindaco di Londra, Boris Johnson e il Premier in carica, David Cameron.
Per quest’ultimo, dopo il trionfo alle elezioni generali del 2015 e successivamente alle amministrative, il referendum costituisce un appuntamento cruciale per il suo futuro politico. Nell’ultimo periodo Cameron si è speso molto per assicurare all’Inghilterra “un ruolo di leadership in un’Unione Europea riformata”, forte dell’accordo siglato a Bruxelles il 20 febbraio che sotto vari aspetti conferma lo status speciale del Regno Unito in Europa. Dopo essersi fatto promotore del referendum, la partita si è però complicata: il Premier si trova ad affrontare delle fratture interne al Governo, con alcuni esponenti apertamente schierati sulla posizione del “Leave”, tra tutti il Ministro della Giustizia, Michael Gove. Anche per questo, se il fronte della permanenza nell’UE non dovesse prevalere, si andrà quasi certamente alle elezioni anticipate. Nel frattempo, nonostante le numerose critiche rivolte al Governo, con Cameron si schiera anche il Labour Party, capeggiato dal leader Jeremy Corbin e dal neo Sindaco londinese Sadiq Khan.
Le difficoltà di Cameron sono ben note a Boris Johnson, che sul trampolino della Brexit cerca di strappare la leadership dei Tories. E ovviamente sul comitato per il “Leave” è immediatamente confluito l’UKIP di Nigel Farage, da sempre a favore di un’uscita dall’UE.
Tornando ai toni della campagna referendaria, è facile notare come con l’avvicinarsi della data del voto, il dibattito si sia gradualmente acceso nel tentativo di entrambi i comitati di far pendere l’ago della bilancia a loro favore.
Il comitato del “Leave” batte su quei temi dove la sensibilità della popolazione è più forte (lavoro, immigrazione, sicurezza) spesso e volentieri snocciolando a sostegno dell’uscita dati fittizi o manipolati a tal punto da essere stato accusato di falsa propaganda dal Financial Times e dall’Istituto Nazionale di Statistica Britannica. A ciò si aggiungono le dichiarazioni provocatorie di Johnson e di Farage: il primo ha recentemente paragonato l’Unione Europea al regime dittatoriale nazionalsocialista, mentre il leader dell’UKIP ha indicato la permanenza nell’UE come il principale fattore responsabile dell’aumento degli stupri in Inghilterra. Elementi che trovano terreno fertile in una popolazione che non ha mai espresso un pieno apprezzamento dell’Unione Europea, tant’è che gli ultimi sondaggi danno il fronte del “Leave” in vantaggio con un’oscillazione tra i 10 e i 19 punti percentuali.
Più arduo il compito del comitato del “Remain” che anziché parlare con statistiche alla mano ha puntato fin da subito sulla necessità di sventare un salto nel vuoto del quale non si conoscono le conseguenze, tranne una: Cameron, esagerando, non si è fatto scrupoli a parlare esplicitamente di “rischio di guerra” in caso di disgregazione del progetto unitario.
Venendo alle conseguenze, in apertura abbiamo già accennato alla difficoltà di prevedere quali saranno gli effetti di un’ipotetica uscita dell’Inghilterra dall’UE. Esistono molte macrovariabili: una di queste è l’articolo 50 del trattato di Lisbona che prevede la possibilità di uno stato in uscita di trattare per due anni le nuove condizioni dei rapporti con Bruxelles. Tutto dipende dunque da quelle che saranno le richieste dell’Inghilterra e quindi da quali vantaggi riuscirebbe a mantenere o a perdere. C’è poi una variabile psicologica legata al timore di instabilità che in parte ha già intaccato i mercati e le loro rispettive interconnessioni.
Secondo uno studio della Bertelsmann Stiftung, dal punto di vista economico, l’uscita dall’UE costerebbe agli inglesi circa 313 miliardi di € con un PIL in contrazione del 14% nell’arco di 12 anni. Per quanto riguarda l’UE, gli effetti sarebbero meno gravi, ma comunque rilevanti, a cominciare dalla necessità di compensare la mancanza dei contributi britannici al budget europeo aumentando le somme versate dagli stati membri.
Nel conto vanno considerate anche le conseguenze politiche che scaturiranno sia sul fronte interno che estero. A cominciare dalla Scozia, che in caso di vittoria del “Leave” potrebbe richiedere un nuovo referendum per l’indipendenza per poi confluire nell’UE (la Scozia al momento è l’area più favorevole al “Remain” con quote che sfiorano il 60%). In Irlanda si fa apertamente il tifo per il “Leave”, così da poter catalizzare ulteriori investimenti da parte delle multinazionali a seguito dell’uscita di Londra. Per quanto riguarda gli altri stati membri, l’addio dell’Inghilterra sarebbe come gettare benzina sul fuoco già vivo alimentato dai movimenti populisti e anti-euro (ad esempio Lega Nord, Front National Francia e FPÖ) e potrebbe innescare un effetto a catena soprattutto negli stati del sud Europa da tempo stufi delle politiche di austerity imposte da Bruxelles (Grecia, Italia, Spagna, Portogallo). Ma c’è anche chi sostiene che la fuoriuscita di una voce dissidente come quella di Londra potrebbe favorire la nascita di un’Europa più unita e forte, sia sul fronte della difesa che su quello del sistema fiscale unitario.
Con questi elementi dunque, il popolo britannico si avvicina a un appuntamento che l’Economist ha inserito nella top 5 dei possibili scenari catastrofici. Nel frattempo, l’Italia e gli altri stati osservano attentamente la partita tra “Leave” e “Remain”, ponderando se puntare sul bianco o sul nero per massimizzare i propri interessi e con la consapevolezza che, a prescindere dal vincitore, dopo il 23 Giugno le regole del gioco non saranno più le stesse.